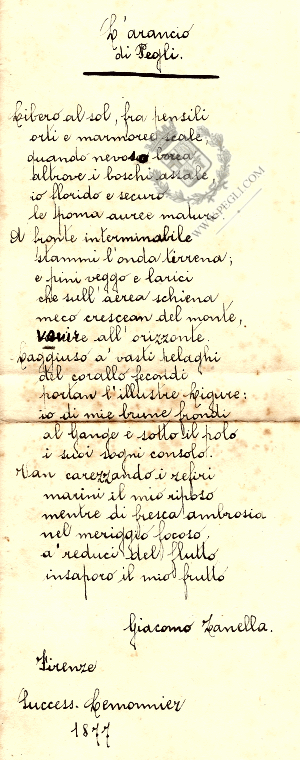L'opera poetica e i temi della poesia di Zanella
un trentennio, dal 1860 al 1887. Con queste date si può fissare il periodo della sua maturità poetica, senza però dimenticare i componimenti anteriori a questo periodo che, anche se sono stati per lo più rifusi o rinnovati del tutto posteriormente al 1860, conservano, nella loro prima stesura, elementi e temi non privi di originalità e anticipatori di motivi che saranno poi sviluppati nelle poesie più tarde.
Il tema di Psiche
« O dell'anima umana, a cui fatale
È sovente del ver la conoscenza,
Immagine gentil, Psiche immortale. »
Del 1847 sono le terzine che hanno per titolo Psiche traduzione libera di un'elegia latina di Carlo Bologna, professore nel seminario vicentino e scrittore di prose e poesie latine. Il tema di Psiche è certamente uno di quei temi di lunga tradizione. Lo predilesse l'arte greca e lo trattò per la prima volta Apuleio. Ne fu attratto l'elegiaco Ippolito Pindemonte, vi si ispirò Canova per una delle sue più belle sculture, a Psiche Prati intitolò una Raccolta di sonetti e al mito di Psiche tornerà anche Pascoli.
Zanella, nel discorso Della filologia classica, dirà: "Presso i Greci è rimasto quel vaghisimo traslato di psiche, farfalla, dato all'anima, che infinita nelle sue brame si gitta avidamente sovra tutti i beni e li sfiora, senza mai trovare quaggiù quell'Uno che possa arrestarla nel leggero ed inquieto suo volo".
Il tema della patria nelle poesie del 1848
Del novembre 1848 abbiamo i versi Ad un amico abile suonatore di pianoforte (l'amico è Fedele Lampertico) che è quanto ci resta di quella poesia patriottica e civile composta prima del 1851, anno in cui, il poeta fu costretto, a causa della perquisizione austriaca, a distruggere tutte quelle poesie che potevano in qualche modo destare i sospetti della polizia. La voce dell'ispirazione patriottica è, senza dubbio, nel poeta, una voce minore. Manca, in questa, quella impetuosità, quella forza che possiamo trovare ad esempio in Carducci di Giambi ed Epodi, ma comunque si possono trovare, senza quindi considerarla del tutto e senza scampo poesia negativa, elementi e temi di notevole interesse. La radice prima dell'amor di Patria di Zanella è da ricercare in quella prima educazione classicistica ricevuta nel Seminario Vicentino; precisamente in quel particolare clima in cui venivano favorevolmente accolte le opere di Giordani, di Gioberti, di Mamiani. I versi Ad un amico, maturano proprio in quell'anno 1848, in cui, dopo l'elezione di Pio IX, il Primato del Gioberti andava a ruba, e uomini, come Paolo Mistrorigo, accendevano la gioventù di Vicenza alla guerra contro l'Austria, e Zanella stesso non mancava di tenere, nella Chiesa di S. Caterina, alcune prediche che fremevano di amor di patria. Manca, in questa poesia, furore ed impeto esaltante, e non vi è, in essa, nulla di romantico; tutta una formazione classicistica fa qui la sua prima impegnativa prova a contatto con una realtà nuova e moderna. Nasce la poesia come reazione ad una realtà che sembrava annullare i frutti di tante lotte e di tanti sacrifici e spegnere tante illusioni. Alla realtà il poeta oppone il sogno tentando nei suoi versi un compromesso tra antico e nuovo, pur prevalendo il gusto classico e di nuovo, di romantico veramente, vi è soltanto la materia. Una poetica, dunque, saldamente ancorata ad un gusto e a principi tradizionali, che si apre cautamente ad esperienze nuove.
Il tema della campagna e degli umili nelle prime poesie
Questo compromesso tra antico e nuovo, si delinea negli endecasillabi a Possagno, che sono del 1849, ispirati dalla visita alla patria del Canova. In essi si trova un romanticismo che cerca una misura ideale di equilibrio per costruire il nuovo senza distruggere il vecchio. Il tema della campagna e il tema degli umili, così schiettamente zanelliano, compare per la prima volta in certi versi del 1849 contenuti in una lettera inviata a Fedele Lampertico.
« Grossa, sonante qualche goccia cala;
la colombella si pulisce l'ala
Sui fumaioli e l'anitrella gaia
Impazza starnazzando in mezzo all'aia
Giocondo, il montanaro in sulla porta
Fassi del suo tugurio e si conforta
Rimirando la pioggia che a torrenti
Allegra i boschi e fa fuggir gli armenti. »
Si tratta di un quadretto di estrema semplicità, ma nello stesso tempo di un impressionismo veramente notevole. La colombella e l'anitrella, con quel diminutivo che rende l'immagine più scivolata, si muovono in quell'atmosfera gioiosa creata dal cadere della pioggia in una calda giornata di agosto, con un'immediata evidenza. Il tema della campagna e dell'umile gente sarà ripresa in una poesia del 1851 Per un mio amico parroco nella quale si avverte un ritmo pacato che contribuisce al formarsi di un concreto ambiente poetico, in cui vivono i parchi coloni e i semplici pastori distribuiti lungo quelle strade di campagna che profumano di fiori, in un giorno di festa fra i dolci richiami delle campagne. Lo Zanella dell'Astichello è già tutto qui, in questa capacità di cantare un mondo costituzionalmente religioso, un mondo di povera gente, ma ricco di fede e di speranza.
Il tema della patria nelle poesie dal 1867 al 1870
Gli anni dell'"????" poetica del vicentino coincidono con l'unificazione d'Italia e con i difficili inizi della vita del nuovo Stato ed è esaminando le sue poesie patriottiche che veniamo a conoscenza di uno Zanella ben vivo nel suo tempo, partecipe delle passioni delle generazioni risorgimentali.
Nell'ode A Camillo Cavour (1867) il tema della Patria ritorna con particolare desiderio d'impegno, ma, anche questa poesia, così come per le prime di carattere patriottico, manca di calore, ed è priva, ad una attenta analisi, di qualunque nota degna di rilievo. Così in una poesia del 1868 intitolata Madre un'altra volta, si sente qualcosa di forzato e di voluto più che di sentito e sofferto. Forse è vero che Zanella fa troppo spesso, in questi versi, dell'oratoria, ma certo è che anche l'eloquenza, se è sostanziata da amore e pensiero, ha una sua validità. Zanella credeva nella missione divina di Roma e sperava che l'Italia ritrovasse l'unità e la potenza antica. Più originale La guerra nel settembre 1870, in cui non si trovano più i temi della letteratura risorgimentale, ma un cristiano, anche se languido, senso della tragicità della guerra. Tale nuovo sentire è permeato da una vaga humanitas virgiliana e a rendere belli questi versi, forse non poeticamente perfetti, è un alto sentimento umano, un accoramento sincero, una partecipazione commossa al destino delle genti che soffrono. In un'altra poesia, La battaglia di Monte Berico, il poeta rievoca tutti i Vicentini, dai giovani alle canute fronti, che avevano combattuto valorosamente e che avevano preferito andare in esilio piuttosto che sottostare un'altra volta allo straniero e qui, la voce che canta la Patria, è espressione di sincero sentire. Pertanto, se non si trova in questa poesia patriottica, l'impeto di un Carducci, troviamo altri elementi validi e grandi. Quel vedere una virtù di rinnovamento nelle stirpi umane, quella fede nella rinascita dell'Italia, è quello stesso sentire che gli fa cogliere una potenza vitale in tutto il cosmo, quel sentimento altissimo da cui nasce tutta la poesia.
Il tema degli umili nelle poesie più tarde
Zanella celebra ed esalta, nei suoi versi, una umanità oscura, umile e laboriosa che con la fatica, con la lotta, col lavoro sano ed onesto si procura il pane per vivere. Si potrebbe pensare, per questa socialità che aleggia nelle sue poesie, a certe derivazioni pariniane, ma il realismo sociale di Zanella è differente da quello di Parini, e questo perché in Zanella il realismo trova un limite nel suo gusto classicamente educato, che non lo lascia andare al di là del sentimento e gli impedisce di fare di esso, come per il Parini, un problema di stile e di linguaggio. Come già in Possagno, così nella lirica Il lavoro (1865), il poeta canta la potenza e la capacità creativa della fatica umana. Vi è in questi versi, fiducia immensa nel lavoro, fede in Dio che guida la mano dell'uomo, esaltazione gioiosa del lavoro umano contro l'ozio. Nella poesia L'Industria, l'approvazione del poeta va alla diffusione delle macchine, che si sostituiscono all'uomo nelle fatiche più aspre, e che ne affermano indirettamente la dignità. Egli prese a cuore il problema del latifondo che affliggeva l'economia nazionale e lo espresse nella lirica Risposta d'un contadino che emigra. Nel Piccolo calabrese Zanella propose il triste problema dell'inumano commercio che avveniva nelle Calabrie, dei fanciulli condotti all'estero e costretti a mestieri infami.
Il tema della famiglia
Ed è sempre tra gli umili che egli vede realizzato il suo ideale di famiglia, perché ritiene che proprio tra la povera gente si faccia più solido il mondo degli affetti.Nella poesia Due vite egli riesce a cogliere e a fermare, con estrema semplicità, un ambiente dall'atmosfera intima, un momento di vita, creando un delizioso quadretto familiare. In questa lirica il poeta contrappone alla vita d'un uomo che, per gioie meno pure ha sempre rifiutato quelle del matrimonio, la vita di un vecchio contadino che ha lavorato con serena fatica e immensa fede, e che ora si trova, nell'ultima età, contornato da una lieta e numerosa famiglia. Al tema della quiete domestica si ispira un'altra poesia: Il mezzogiorno in campagna (1870), poesia già vicina, e come stile e come contenuto, ai sonetti dell'Astichello. Troviamo infatti quegli elementi e temi fondamentali: l'amore per le creature, la religiosità in tutte le cose, che saranno sviluppati e ripresi in quei versi di esaltazione delle creature e del loro creatore.
Zanella e il positivismo
Come nel campo della letteratura Zanella, partito da una formazione fondamentalmente classica, era giunto poco a poco ad aderire alle tendenze romantiche, così anche sul piano della formazione filosofica, dopo aver subito l'influsso del sensismo, si era rivolto allo spiritualismo, dedicandosi allo studio delle opere di Galuppi, di Rosmini e di Gioberti e aveva chiesto che si desse, contro il positivismo e il determinismo, allora in voga, maggior posto ai valori spirituali.Nella dedica a Fedele Lampertico della prima edizione dei suoi versi, scrisse: "I soggetti che più volentieri ho trattato sono quelli di argomento scientifico, ma non è già l'oggetto della scienza che mi paresse capace di poesia, bensì i sentimenti che dalle scoperte della scienza nascono in noi; per questo non ho mai posto mano ad uno di questi soggetti, che prima non avessi trovato il modo di farvi campeggiare l'uomo e le sue passioni, senza cui la poesia, per ricca che sia d'immagini, è senza vita".Era senza dubbio nei suoi propositi di fare una poesia scientifica, ma Zanella si accorse presto che il sapere scientifico si poneva al livello di un sapere assoluto, e quindi in aperto contrasto con la Fede. Zanella era profondamente cattolico e quando si trattò di portare sul piano pratico quelle idee, così chiaramente espresse in prosa, l'iniziale trasporto venne ad essere frenato e scosso da altre preoccupazioni inevitabili alla sua anima religiosa.Egli si trovava dinanzi al perpetuo problema della sintesi e quindi dei rapporti tra l'umano e il divino, problema che al tempo di Zanella si espresse storicamente con la polemica anticlericale dei positivisti liberali e razionalisti. Nel poemetto Milton e Galileo, del 1868, questo problema viene esposto in termini molto elevati.
Il tema della scienza e della fede
Nella poesia zanelliana il tema della scienza è pertanto necessariamente collegato con il tema della fede. Nei versi Ad un'antica immagine della Madonna, del 1863, il poeta contrappone la fede semplice degli umili alle teorie superbe dei filosofi, che pretendono di abolire la religione sostituendo ad essa le nuove leggi scientifiche. Un'altra protesta contro le nuove teorie del secolo, e, in questo caso, contro il darwinismo, è espressa nella poesia La veglia, ma mentre nella precedente poesia, lo sdegno che si esprime in versi dopo il dolcissimo canto alla fede, non ha note stonate, questo avviene nei versi de La Veglia. Così in Microscopio e Telescopio si trovano lo stesso dolore per la mancanza di fede, per la superbia dell'uomo che crede di sostituire Dio e di svelarne i misteri. Il tema del mondo odierno che, superbo delle sue scoperte, ha dimenticato la fede degli avi, ritorna in altre odi come nella poesia Pel taglio di un bosco o negli endecasillabi Alla Madonna di Monte Berico. Nella poesia L'Imitazione di Cristo, il problema del rapporto umano-divino viene risolto riducendo al minimo il termine umano. Il sentimento religioso è qui cantato con perfetta coerenza. Eppure Zanella pur esprimendo in molte poesie il suo disprezzo per certe dottrine che sembrano distruggere i fondamenti dell'antico sapere, come il materialismo (in una poesia intitolata Sopra certi sistemi di filologia, composta nel 1877), ammirava certe opere del progresso, come ad esempio nella poesia Il taglio dell'Istmo di Suez. Zanella fu dunque certamente suggestionato dalle conquiste della scienza, ma egli non cercò di sciogliere i problemi allora dibattuti cercando di trovare qualche nuova e valida sintesi di natura filosofica e teologica. Zanella aveva in sé troppo saldi i motivi dell'ortodossia cattolica perché si lasciasse suggestionare, in senso eterodosso, dagli splendori delle scienze e delle filosofie. Dobbiamo rilevare inoltre, che vi fu in Zanella un forte contrasto tra il momento ideologico e il momento poetico. Questo perché in prosa poteva esprimere chiaramente le sue idee che nascevano dal sentimento e dalla fede, ma in poesia il sentimento e la fantasia non riuscivano ad essere contenute, e veniva così a mancare il necessario equilibrio per poter scrivere vere poesie di scienza.
Il tema del cosmo
Ma uno degli aspetti più interessanti e più nuovi della poesia zanelliana, non sta certamente nella poesia che s'ispira alla storia, o alla natura o alla scienza, ma in quella particolare poesia astrale che ha per tema il cosmo. Già tra le prime poesie di Zanella si avverte, in alcuni versi inediti è[7] del 1858, questo tema, assai nuovo per quei tempi. Ed è senza dubbio singolare l'apparizione in questi versi del motivo che prelude ad esperienze di poeti moderni, in un periodo in cui il poeta sembrava ancora strettamente legato al passato. Eppure è indubbio che in questi versi appare per la prima volta un cielo, che non è quello della tradizione classica, ma un cielo già scientifico:
« Nonna che dici? Io mi credea che i milli
Che mi additi lassù, punti lucenti,
Non fossero pianeti e soli ardenti,
Rotanti nimbi ed iridi tranquille.
Io fori li credea, donde faville
Sprizzan quaggiù dai fulgidi torrenti,
Che di dentro fan belli i firmamenti;
Perché levansi a Dio nostre pupille. »